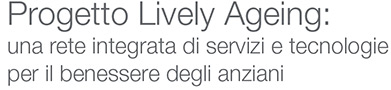Le indagini della comunità scientifica internazionale sul benessere degli anziani
La comunità scientifica offre spunti di riflessione interessanti relativi agli stili di vita anziani e ai fattori di prevenzione di natura fisica, cognitiva e sociale. Tutte queste scoperte e innovazioni consentono ai professionisti del settore di mettere a punto buone prassi correlate al benessere degli anziani e di progettare linee di intervento sempre più consapevoli.

Raccontare di sé in versione digitale
Bossio D., McCosker A., Schleser M., Davis H., Randjelovic I. (2023). Not that old person: Older people’s responses to ageism revealed through digital storytelling. Journal of Sociology, 59(1), pp. 232-250.
Nel recente studio di natura sociologica condotto da Bossio e colleghi, alcuni soggetti anziani – dai 70 anni in avanti – hanno avuto la possibilità di raccontare di sé e delle loro abitudini quotidiane tramite brevi narrazioni digitali. Da un lato il raccontare di sé e delle proprie attività consente di sensibilizzare la popolazione circa il tema della vecchiaia attiva e di abbattere gli stereotipi che propongono un’idea delle persone anziane come non più capaci di (ageismo). Dall’altro lato offre l’opportunità ai narratori di percepirsi in maniera positiva e propositiva, di ripercorrere le attività di routine e di mostrare i propri luoghi di vita spostando l’attenzione sui punti di forza, sulle competenze e non sulle difficoltà correlate all’avanzare dell’età. Ad essere raccontate e riprese dai narratori sono attività quotidiane come la coltivazione dell’orto di famiglia oppure la preparazione dei pasti principali.
Un robot sociale per diminuire le sensazioni di solitudine provate durante la pandemia da Covid-19
Ito K., Suzumura S., Kanada Y., Narukawa R., Sakurai H., Makino I., Kondo I. (2022). The use of a companion robot to improve depression symptoms in a community-dwelling older adult during the coronavirus disease 2019 state of emergency. Fujita Medical Journal, pp. 2021-2024.
Il periodo di isolamento sociale causato dalla pandemia da Covid-19 ha scatenato un aumento dei sintomi depressivi e della sensazione di solitudine in età anziana. Lo studio giapponese commentato ha voluto indagare l’effetto di un companion robot sullo stato mentale di una donna di 80 anni che ha dichiarato di non provare più emozioni positive dopo il lockdown: nel protocollo sperimentale, la partecipante ha dovuto “prendersi cura” del robot per almeno un’ora al giorno nell’intero mese di aprile 2020. L’interazione con il robot – il quale era in grado di esibire emozioni sia positive sia negative – ha portato ad alcuni miglioramenti in due direzioni. Dal punto di vista psicologico, si è notato – grazie alla Self-Rating Depression Scale – un aumento dei livelli di soddisfazione scaturiti dalle azioni correlate al to care, mentre dal punto di vista fisico – grazie alla Functional Independence Measure – si è notato un aumento dei comportamenti salutari (ad esempio, delle uscite all’aria aperta).
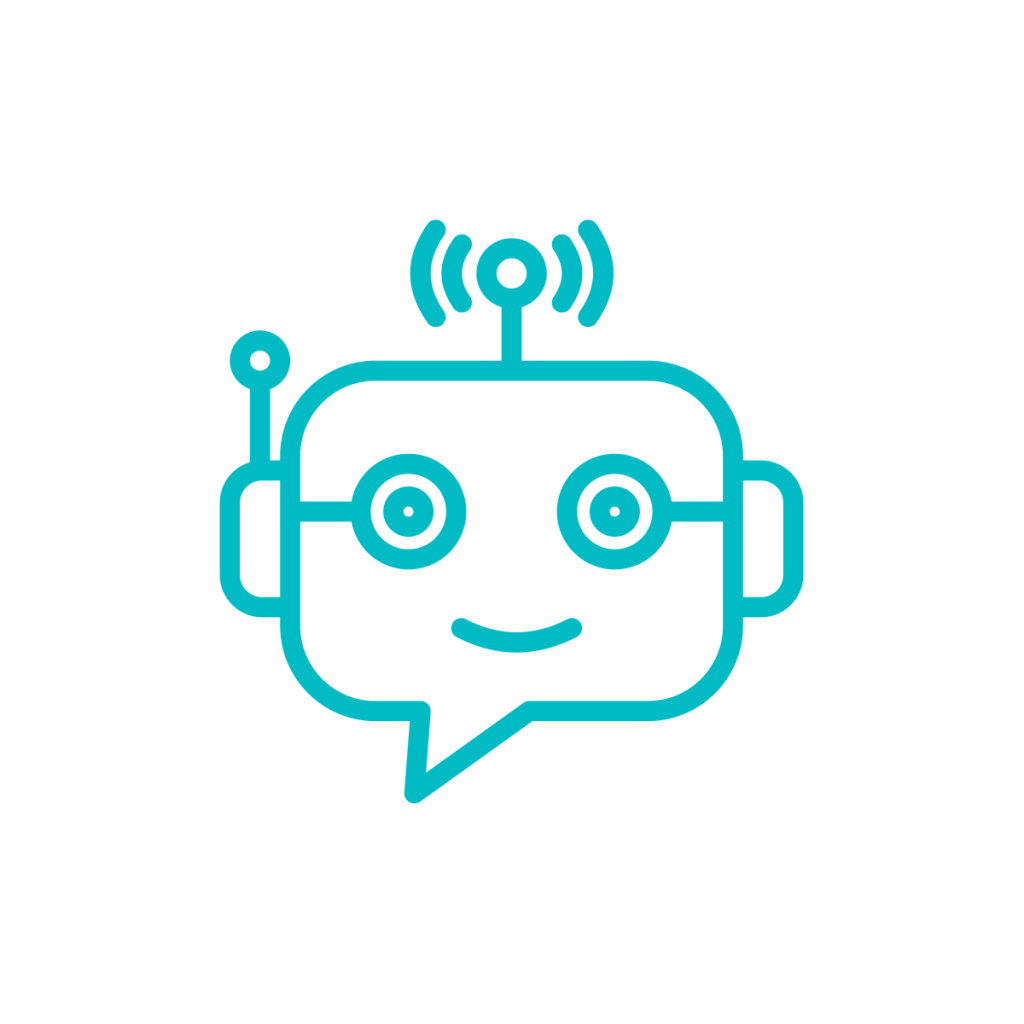

ButterfLife, un dispositivo medico brevettato non invasivo per il telemonitoraggio dei cinque parametri vitali che facilita l’assistenza domiciliare
Salton F., Kette S., Confalonieri P., Fonda S., Lerda S., Hughes M., Confalonieri M., Ruaro B. (2022). Clinical Evaluation of the ButterfLife Device for Simultaneous Multiparameter Telemonitoring in Hospital and Home Settings. Diagnostics, 12(12), pp. 1-13.
Coppi F., Pinti M., Selleri V., Zanini G., D’Alisera R., Latessa P.M., Tripi F., Savino G., Cossarizza A., Nasi M., Mattioli A.V. (2022). Cardiovascular Effects of Whole-Body Cryotherapy in Non-professional Athletes. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 9, pp. 1-8.
La telemedicina è cresciuta rapidamente negli ultimi decenni. Il telemonitoraggio multiparametrico facilita l’assistenza domiciliare dei pazienti, consentendo il riconoscimento precoce del deterioramento clinico e riducendo la necessità di ricovero. Attualmente, ButterfLife è l’unico sistema disponibile in commercio che misura contemporaneamente i cinque parametri vitali più importanti. Nello studio condotto da Salton e colleghi emerge una riconosciuta facilità nell’utilizzo del dispositivo e la maggior parte dei soggetti arruolati sostiene di apprezzare il telemonitoraggio quotidiano. ButterfLife si è dimostrato anche uno strumento efficace per evidenziare varie condizioni patologiche, consentendo la loro gestione al di fuori dell’ospedale prima della comparsa dei sintomi.
ButterfLife può essere utilizzato per il monitoraggio dei parametri vitali anche nella popolazione sana, come ad esempio persone anziane autosufficienti e atleti professionisti o amatoriali. Nello studio condotto da Coppi e colleghi sono state analizzate le variazioni di frequenza cardiaca, pressione arteriosa, frequenza respiratoria, saturazione dell’ossigeno e temperatura corporea in corridori non professionisti durante trattamento in un criocamera. Dal momento che negli ultimi anni, la crioterapia si è diffusa anche tra gli atleti non professionisti e i soggetti adulti/anziani per i suoi effetti antinfiammatori e correlati all’antinvecchiamento, è stato fondamentale verificare la sicurezza di questa metodica soprattutto a livello cardiovascolare, tramite l’utilizzo di ButterfLife.
TimeSlips. La creatività e l’immaginazione al servizio delle competenze cognitivo-relazionali
Basting A. D. (2013). TimeSlips: Creativity for people with dementia. Age in Action, 28(4), pp. 1-6.
TimeSlips è un programma di intervento messo a punto da Anne Basting (docente di Teatro presso l’Università del Wisconsin) che prevede la predisposizione di attività narrative creative dedicate a soggetti anziani/affetti da patologie neurodegenerative. L’obiettivo principale del programma è proporre attività di storytelling che consentono di allenare competenze preziose come l’immaginazione e la creatività e di “oltrepassare” le frustrazioni correlate alle difficoltà mnemoniche autobiografiche. Dal punto di vista del setting, i partecipanti hanno la possibilità di creare brevi narrazioni in un formato “a piccolo gruppo” e particolare importanza ha la figura del “facilitatore”. In un primo momento viene proposto uno stimolo-creativo iconico e successivamente, a partire da questo elemento, i soggetti iniziano a dare vita a trame creative . Durante la fase di elaborazione narrativa, il facilitatore guida l’interazione con opportune domande-chiave del tipo who, what, where: Chi sono i personaggi dell’immagine? Cosa stanno facendo? Come si sentono? Cosa può essere accaduto prima e cosa può accadere dopo? In questo ambiente narrativo failure-free, ciascun partecipante ha la possibilità di aggiungere informazioni alla trama condivisa e di esprimersi sì attraverso il codice verbale, ma soprattutto attraverso il codice gestuale e corporeo.
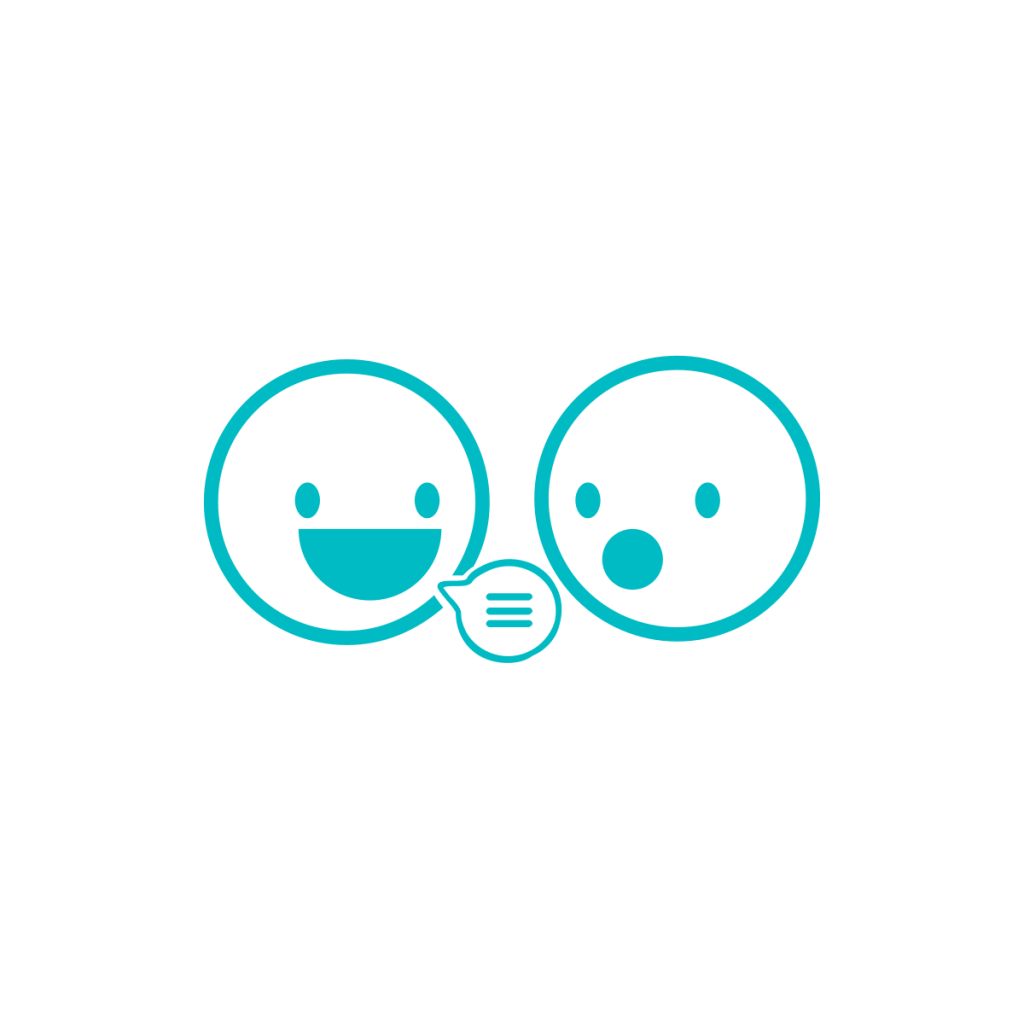

Leggere, per vivere meglio
Wang Y., Wang S., Zhu W., Liang N., Zhang C., Pei Y., Shi J. (2022). Reading activities compensate for low education-related cognitive deficits. Alzheimer’s Research & Therapy, 14(1), pp. 1-12.
In una società in cui la popolazione diventa sempre più anziana, è essenziale sviluppare strategie che consentano di rallentare il decadimento cognitivo: una buona pratica di prevenzione ha a che vedere con la lettura. L’articolo di Wang e colleghi riporta i dati provenienti da uno studio prospettico condotto dal Centro nazionale cinese di Ricerca sui disturbi neurodegenerativi (CANDOR) che ha voluto indagare il ruolo della lettura nel mantenimento delle competenze cognitive. I partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi sperimentali considerando due variabili: gli anni di istruzione e il numero di libri letti. Il risultato principale? La lettura può essere ritenuta più di un piacevole hobby. Il gruppo di lettura ha ottenuto prestazioni cognitive migliori rispetto al gruppo di non lettura, in particolare per ciò che riguarda i soggetti con minor livello di istruzione e per ciò che riguarda il linguaggio, la memoria non verbale e le funzioni esecutive. Date le difficoltà correlate alla vista e alla decodifica del testo scritto, la tecnologia può essere considerata un valido supporto: gli audiolibri, strumenti sempre più alla portata di tutti, consentono di fruire del materiale narrativo in un formato inclusivo.
La realtà virtuale immersiva al servizio del benessere psico-sociale
Restout J., Bernache-Assollant I., Morizio C., Boujut A., Angelini L., Tchalla A., Perrochon A. (2023). Fully Immersive Virtual Reality Using 360° Videos to Manage Well-Being in Older Adults: A Scoping Review. Journal of the American Medical Directors Association, pp. 564-572.
Durante l’invecchiamento può capitare che emergano sensazioni negative correlate a stati di ansia, solitudine e depressione e per questa ragione è necessario proporre attività educative utili per contrastare queste tendenze. Le evidenze riassunte nella review suggeriscono che le nuove tecnologie, come la realtà virtuale immersiva (VR), costituiscono strumenti terapeutici che consentono di intervenire sugli outcomes psicosociali anziani. Con realtà virtuale immersiva si intende una forma avanzata di realtà virtuale (VR) che mira a creare un ambiente digitale autentico e che consente all’utente di sentirsi proiettato al suo interno. Grazie alla VR, i soggetti possono navigare liberamente spazi altri rispetto alla realtà come i setting naturali oppure luoghi interessanti dal punto di vista turistico. Quali benefici e quali limiti contraddistinguono queste attività? Tutti gli interventi sperimentali considerati nella review hanno sottolineato gli esiti positivi di natura emotivo-motivazionale: la possibilità di trovarsi in una dimensione altra sembra favorire una diminuzione significativa dell’apatia e la comparsa di interessi nuovi. Gli effetti su altri fattori psicologici hanno dato risultati contrastanti, ma promettenti. Alcuni studi che hanno incluso partecipanti con deficit cognitivo, ad esempio, hanno mostrato un effetto benefico della VR su parametri come l’ansia sociale e la qualità della vita. In merito alla cybersickness – la possibilità di non reagire bene all’interazione con una realtà diversa da quella fisica – quasi tutti i partecipanti hanno trovato l’esperienza piacevole, realistica e generatrice di stati d’animo piacevoli.
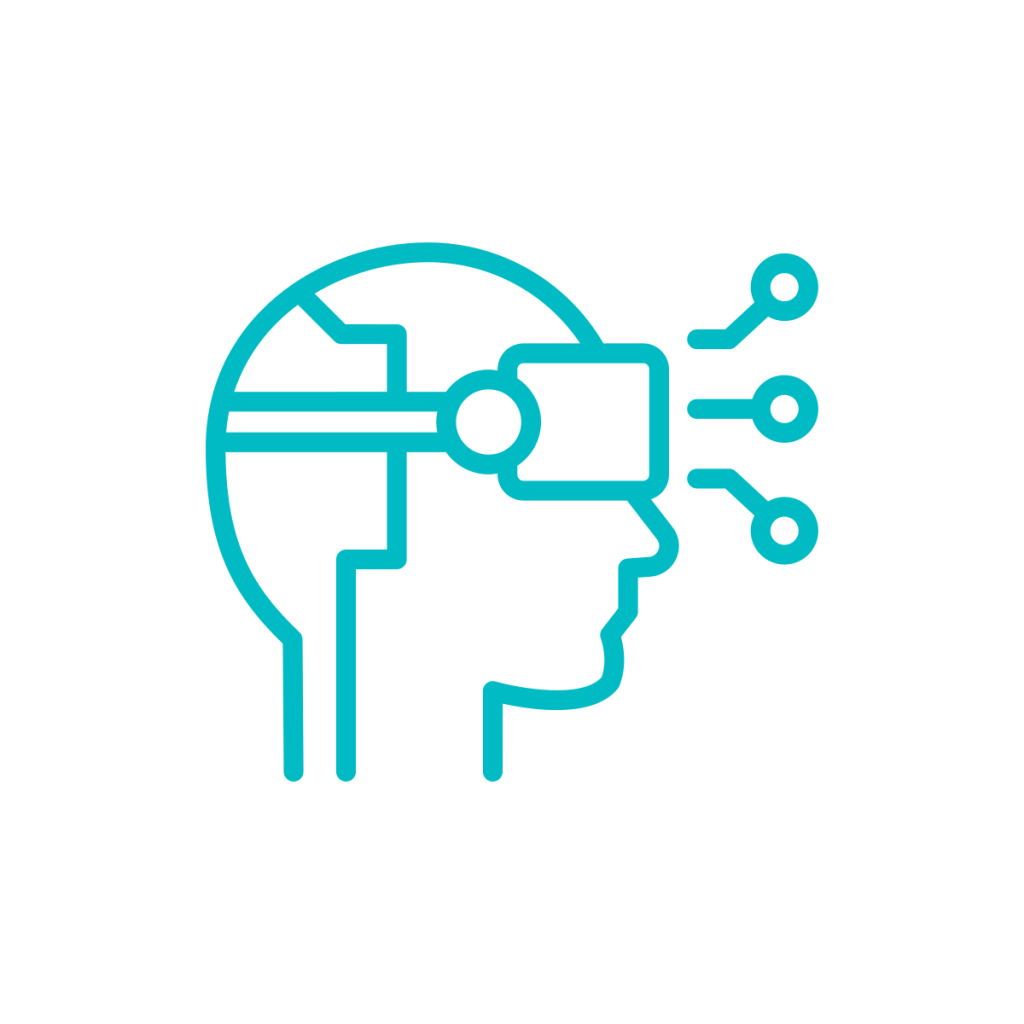

La realtà virtuale non immersiva per il benessere motorio e cognitivo
Maranesi E, Casoni E, Baldoni R, Barboni I, Rinaldi N, Tramontana B, Amabili G, Benadduci M, Barbarossa F, Luzi R, Di Donna V, Scendoni P, Pelliccioni G, Lattanzio F, Riccardi GR, Bevilacqua R. (2022). The Effect of Non-Immersive Virtual Reality Exergames versus Traditional Physiotherapy in Parkinson’s Disease Older Patients: Preliminary Results from a Randomized-Controlled Trial. International Journal of Environmental Research and Public Health. 19(22), pp. 2-11.
Il Parkinson è una patologia che interessa l’encefalo caratterizzata da un progressivo peggioramento motorio. Le Linee Guida raccomandano la predisposizione di una terapia fisica precoce, ma ancora non esistono evidenze dei benefici in termini di prevenzione di insorgenza dei sintomi avanzati. Per questa ragione, identificare nuove metodiche per contrastare la disabilità è una priorità nel percorso di riabilitazione. Recenti studi hanno dimostrato come l’introduzione di proposte tecnologiche, come la realtà virtuale non immersiva , possa incentivare un coinvolgimento motorio-cognitivo personalizzato. Lo studio ha messo a confronto i risultati della fisioterapia tradizionale nei pazienti affetti da malattia di Parkinson con quelli ottenuti attraverso una nuova strategia di riabilitazione tecnologica che prevede l’utilizzo della realtà virtuale non immersiva. Il gruppo di controllo si è sottoposto a riabilitazione tradizionale (esercizi di respirazione, di cammino, di equilibrio) per 50 minuti, mentre il secondo gruppo si è sottoposto per i primi 30 minuti alla riabilitazione tradizionale e per i restanti 20 minuti a esercizi ludici svolti con il sistema Tymo. Dal punto di vista motorio, l’analisi dei dati ha evidenziato un netto miglioramento dell’equilibrio nel gruppo sottoposto a riabilitazione digitale. Un altro risultato degno di nota riguarda l’efficacia della realtà virtuale nel miglioramento del benessere mentale.
Il disegno al servizio della memoria
Meade M. E., Ahmad M., Fernandes M. A. (2020). Drawing pictures at encoding enhances memory in healthy older adults and in individuals with probable dementia. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 27(6), pp. 880-901.
Il deterioramento mnemonico può influenzare la routine dei soggetti anziani, così come il loro stato d’animo e la qualità della vita. È allora bene chiedersi quali strategie compensative possono essere proposte. Sono numerosi gli studi di psicologia che hanno approfondito il ruolo del disegno, inteso come stratagemma privilegiato di memorizzazione e di recupero. Ragazzi e anziani sembrano memorizzare maggiormente i concetti quando li disegnano nella fase di codifica (e non quando scrivono le parole di riferimento): il beneficio psicologico prende il nome di drawing effect e sembra dipendere dalla preziosa integrazione tra dimensione semantica, motoria e pittorica che il disegno porta con sé. La possibilità di rappresentare graficamente un elemento coinvolge simultaneamente il meccanismo semantico di attribuzione del significato, il meccanismo noto come pictorial information, il movimento e gli aspetti generativi del pensiero. A decretare il predominio del materiale iconico nel processo mnemonico sembra essere anche il network cerebrale attivato: le aree che si mantengono particolarmente intatte nel tempo sembrano essere quelle visive, quelle che contraddistinguono il cosiddetto ventral visual pathway. Il principale obiettivo dello studio è comparare i benefici mnemonici che derivano dalla scrittura e dal disegno in anziani sani e in anziani con difficoltà di natura cognitiva. Ai partecipanti viene chiesto di osservare alcune parole in uno schermo e di ri-scriverle sul foglio oppure di disegnarle. Terminata questa prima fase, viene proposto un compito mnemonico di recupero durante il quale i partecipanti devono richiamare liberamente le parole considerate e riconoscerle all’interno di una lista preconfigurata. A interessarci è il fatto che ad essere recuperati maggiormente da entrambi i gruppi sperimentali sono i termini disegnati, raffigurati. Il processamento semantico e visuale sembra essere decisamente più accurato in caso di disegno e la rappresentazione grafica si presenta come una significativa strategia da proporre nella quarta età.


Il codice iconico come supporto per la comprensione nei contesti sanitari-residenziali
Choi J. (2014). Literature review: using pictographs in discharge instructions for older adults with low‐literacy skills. Journal of clinical nursing, 20(21‐22), pp. 2984-2996.
Spesso i soggetti anziani devono sottoporsi a interventi e devono gestire pratiche di riabilitazione in autonomia per mantenere il loro equilibrio fisico. Altrettanto spesso accade che il periodo del recupero non vada come previsto a causa della mancata aderenza alle indicazioni fornite dai professionisti sanitari. Nella maggior parte dei casi, i materiali che vengono consegnati ai pazienti – anziani e non – sono brevi testi che suggeriscono e ricordano le azioni da fare e da non fare. La lettura e la rielaborazione di questi materiali non è un passaggio semplice per i soggetti di una certa età sia a causa della difficoltà correlata al processo di decodifica verbale sia a causa della difficoltà causata dall’elevato numero di informazioni proposte. Tra gli approcci informativi innovativi suggeriti nel mondo della cura troviamo le figure che sostengono la comprensione del materiale con il supporto del codice iconico. Secondo la teoria cognitiva del Multimedia Learning (CTML), per comunicare in modo efficace è necessario favorire la memorizzazione e il successivo richiamo del contenuto. Recenti studi condotti in ambito sanitario hanno trovato che gli individui comprendono meglio le istruzioni nel momento in cui hanno la possibilità di codificare simultaneamente le parole e i simboli iconici corrispondenti. Un interessante strumento è il pittogramma, una linea disegnata che trasmette significato grazie alla somiglianza con un oggetto oppure con un’idea. Nel mondo della cura, il pittogramma consente di proporre alcuni fermi-immagine che simboleggiano gli eventuali step dei piani terapeutici da seguire oppure le attività di routine che devono essere condotte. Grazie alla capacità del simbolo di rendere visibili le azioni, il processo di comprensione sembra essere meno difficoltoso e la compliance sembra migliorare notevolmente. Secondo gli autori, dal punto di vista strutturale, particolare attenzione merita la didascalia, intesa come breve testo che accompagna l’interpretazione del pittogramma, e il livello di realismo della figura.
Tempo, emotività e funzioni cognitive
Carstensen L. L. (2006). The influence of a sense of time on human development. Science, 312(5782), pp. 1913-1915.
Il cosiddetto sense of time ha effetti profondi sui processi umani di base come la cognizione, la motivazione e l’emotività. Poiché il comportamento goal-directed si basa sul futuro percepito, studiose come Laura Carsensten sostengono che la percezione del tempo è strettamente correlata alla selezione degli obiettivi personali. Per la sua teoria della selettività socio-emotiva, il tempo gioca un ruolo chiave a livello di motivazione: sia gli obiettivi sia i processi cognitivi – come l’attenzione e la motivazione – cambiano man mano che gli orizzonti temporali si restringono. Quando il tempo è open-ended gli obiettivi sono focalizzati sulla scoperta, mentre quando è limitato diventano a breve termine, focalizzati sul significato emotivo. Negli ultimi anni, alcuni interventi sperimentali hanno voluto indagare il come gli stati motivazionali – focalizzati sull’emotività – sono in grado di influenzare l’elaborazione delle informazioni. Carsensten e colleghe (2006) hanno trovato che ad essere ricordati sono gli spot pubblicitari con intenti relazionali. Basti pensare che dopo aver osservato due versioni della medesima pubblicità – una conoscitiva con lo slogan “cattura il mondo inesplorato” e una affettiva con lo slogan “cattura i momenti speciali” – i partecipanti sono riusciti a mantenere in memoria solamente i dettagli correlati alla seconda. In un secondo intervento sperimentale, le autrici (2005) hanno chiesto ai partecipanti – giovani e anziani – di osservare alcune immagini emotivamente neutre, positive e negative: nel caso della popolazione senior, hanno scoperto che l’amigdala viene attivata in misura maggiore in caso di materiali emotivi, ma soprattutto nel momento in cui vengono elaborate informazioni prettamente positive. Tra le altre cose, questo effetto sembra avere spiegazioni di natura evolutiva: i materiali negativi contengono svariate informazioni esplicative che sembrano essere particolarmente utili ai più giovani, gli anziani, invece, prediligono la serenità emotiva e per questa ragione attivano l’amigdala in caso di input favorevoli.


Doll therapy. Il prendersi cura e i benefici psicologici e cognitivi
Yilmaz C. K., Aşiret G. D. (2021). The effect of doll therapy on agitation and cognitive state in institutionalized patients with moderate-to-severe dementia: a randomized controlled study. Journal of geriatric psychiatry and neurology, 34(5), pp. 370-377.
Tra gli approcci non farmacologici che possono essere proposti in caso di patologie neurodegenerative troviamo gli interventi cognitivi (come la reminescence therapy) e le opportunità psicosociali (come il contatto con gli animali). Lo studio randomizzato controllato qui commentato si è posto come obiettivo quello di capire se attività come la Doll Therapy – trattamento in cui i soggetti anziani sono invitati a prendersi cura di un oggetto ludico, una bambola – possano essere considerate strategie efficaci per il mantenimento dello stato cognitivo e per il trattamento dei disturbi comportamentali. La bambola può essere considerata uno strumento privilegiato in quanto consente al soggetto che la utilizza di creare un legame affettivo significativo, di rivivere emozioni passate positive e lascia emergere comportamenti relazionali adeguati. Lo studio è stato condotto in una casa di cura in Turchia con soggetti affetti da demenza – tra gli 82 e gli 89 anni – per un periodo di otto settimane. Alcuni partecipanti hanno preso parte al gruppo sperimentale e hanno avuto la possibilità di prendersi cura di una bambola personale, mentre altri sono stati inseriti nel gruppo di controllo. Per verificare i benefici correlati alla pratica ludica, sono stati utilizzati due test di valutazione: la Standardized Mini-Mental State Examination per la valutazione dello stato cognitivo e la Neuropsychiatric Inventory per i disturbi comportamentali. Per quanto riguarda lo stato cognitivo non si è raggiunta la significatività statistica, ma ad essere lievemente migliorate sono le abilità di orientamento e le abilità comunicativo-linguistiche. Le differenze statisticamente significative riguardano, invece, i disturbi comportamentali e l’agitazione psicomotoria: dopo otto settimane i partecipanti hanno esibito un minor numero di comportamenti oppositivi e di ansia.
Orticoltura, movimento e socialità
Farkas V., Simon A., Sztruhár I. J., Gyombolai Z., Kovács É. (2024). Effect of horticultural therapy on static, dynamic balance and gait speed among institutionalized older adults with cognitive impairment. Journal of Complementary and Integrative Medicine, (0), pp. 1-9.
La terapia orticolturale è una terapia non farmacologica che utilizza le piante, le attività di giardinaggio e l’innata affinità che noi sentiamo per la natura come strumento in programmi di riabilitazione. Già dalle epoche più remote come il Medioevo, è stato riconosciuto il valore di queste proposte, le quali correlano positivamente con le funzioni psicologiche, sociali e somatiche degli individui. Lo studio qui commentato è stato condotto con soggetti anziani con difficoltà di natura cognitiva residenti in una casa di cura ungherese, i quali sono stati suddivisi in due gruppi operativi (il gruppo di controllo ha preso parte alle attività quotidiane di manualità, mentre il gruppo sperimentale ha partecipato ad un programma di terapia orticolturale). Per quanto riguarda il secondo gruppo, i partecipanti – per un’ora due volte alla settimana per tre mesi – hanno avuto la possibilità di dedicarsi a svariate proposte di giardinaggio: dalla preparazione del terreno, alla semina, alla potatura e alla raccolta. A rendere visibili i preziosi risultati sono le interviste sottoposte al personale sanitario della struttura: a loro opinione, il gruppo sperimentale ha migliorato le interazioni sociali(ad esempio, ha avviato più conversazioni in autonomia con i coetanei e con le famiglie), ha modificato le routine (ad esempio, ha trascorso più tempo nelle zone comuni e ha preso parte alle proposte educative di altro tipo) e ha ridotto i comportamenti e gli atteggiamenti negativi, come quelli oppositivi. In più, nel corso delle settimane si sono verificati miglioramenti dal punto di vista della salute fisica: i partecipanti hanno esibito un maggior controllo dell’equilibrio statico e della velocità del cammino.
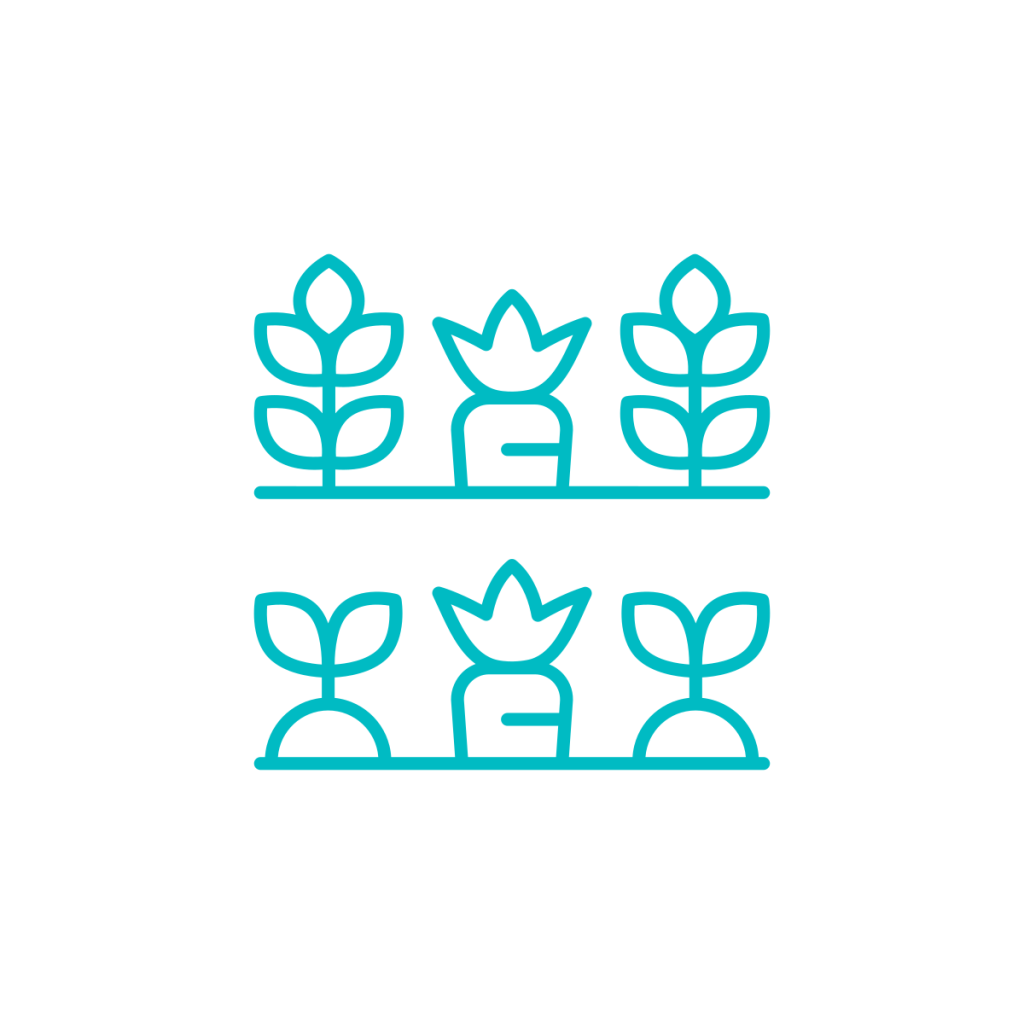
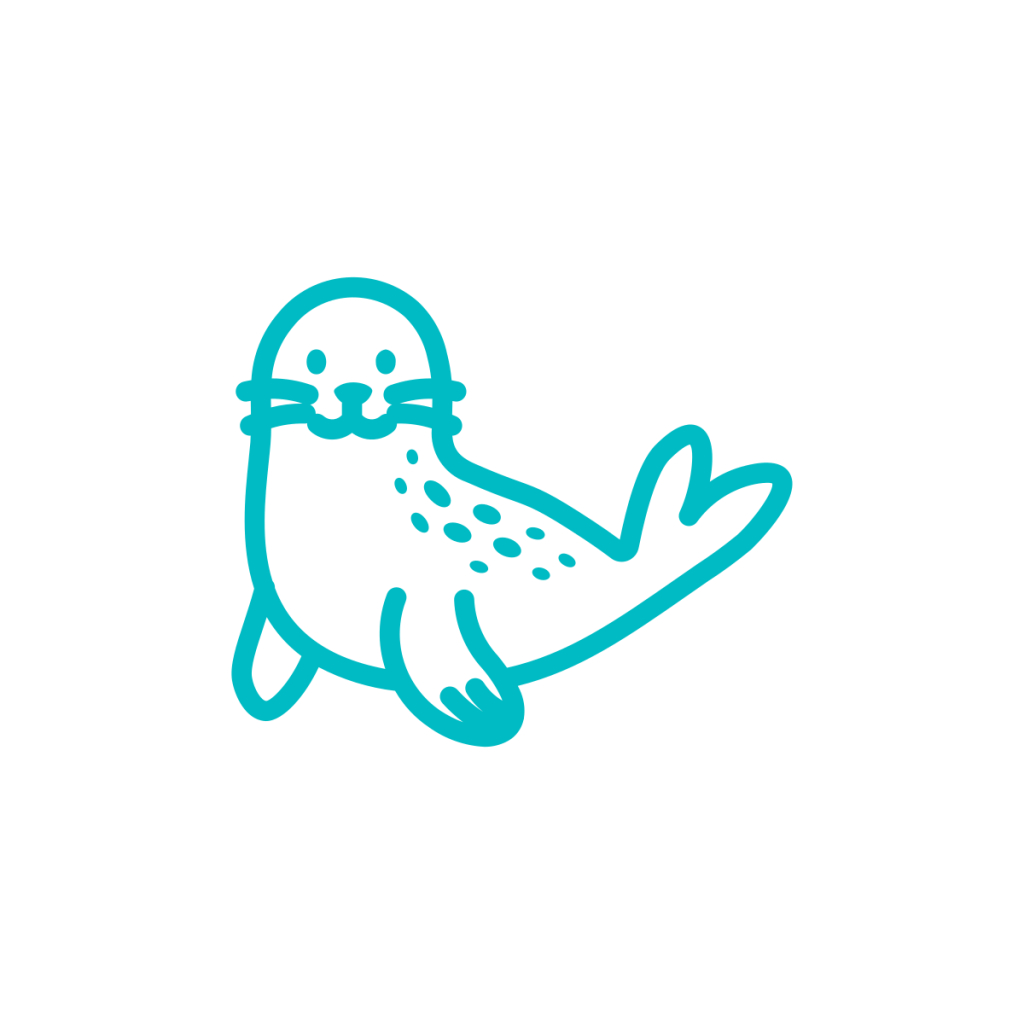
Robot sociali e benefici fisiologici
Robinson H., MacDonald B., Broadbent E. (2015). Physiological effects of a companion robot on blood pressure of older people in residential care facility: a pilot study. Australasian journal on ageing, 34(1), pp. 27-32.
Ricerche recenti hanno notato che gli animali hanno un effetto positivo sulla salute fisica e psicologica dei individui: la possibilità di coccolare un animale consente di ridurre la pressione sanguigna, il livello di cortisolo e dei trigliceridi, di aumenta il livello di ossitocina e dopamina e previene la comparsa di problemi cardiaci come gli infarti. Tuttavia, non sempre è semplice avere un animale personale: per questa ragione, negli ultimi anni sono stati messi a punto paradigmi sperimentali che prevedono l’interazione tra soggetti e robot sociali dalle sembianze animali: questi robot animal-like sembrano essere in grado di creare un’atmosfera positiva dal punto di vista relazionale ed emotivo. Nello studio qui commentato è stata offerta ai partecipanti residenti in una residential care la possibilità di interagire per dodici settimane in un setting laboratoriale con il robot Paro, robot che somiglia ad un cucciolo di foca. Ad essere stati oggetto di analisi sono i parametri fisiologici, come la pressione sanguigna, la quale è stata misurata per tre volte in ciascun incontro (prima, durante il contatto e in seguito). Tra i risultati più significativi troviamo un abbassamento del livello della pressione sia sistolica sia diastolica durante la fase del contatto fisico, ovvero nel momento in cui i partecipanti hanno avuto la possibilità di accarezzare il robot e di instaurare con lui una conversazione. Grazie all’interazione prolungata, alle sue sembianze autentiche e alla comunicazione interattiva del tipo human-based, Paro può essere considerato sì come uno strumento di prevenzione cardio-vascolare, ma al tempo stesso una possibilità per allenare le competenze emotivo-sociali.
Il gioco degli scacchi come opportunità cognitiva ed emotiva
Cibeira N., Lorenzo-López L., Maseda A., Blanco-Fandino J., López-López R., Millán-Calenti J. C. (2021). Effectiveness of a chess-training program for improving cognition, mood, and quality of life in older adults: A pilot study. Geriatric Nursing, 42(4), pp. 894-900.
Negli ultimi anni l’interesse della comunità scientifica è stato rivolto all’identificazione di fattori che consentono di intervenire preventivamente sul declino cognitivo. Tra questi, troviamo le attività ludiche, le quali consentono di allenare le competenze cognitive essenziali – come l’attenzione, la memoria e altre funzioni esecutive – e di salvaguardare la riserva cognitiva. Tuttavia, sono numerosi gli studi che ci riferiscono che il coinvolgimento in stimolanti dal punto di vista mentale consente sì di ritardare il declino cognitivo, ma al tempo stesso di intervenire sulla dimensione relazionale-sociale. Ad essere interessante è il ruolo dei board games, come gli scacchi, intesi come strumenti familiari e conosciuti che permettono di allenare simultaneamente la memoria di lavoro e il ragionamento logico e di sviluppare dinamiche collaborative. Nello studio qui commentato i partecipanti del gruppo sperimentale hanno avuto la possibilità di prendere parte a 24 sessioni di gioco, diversamente dai partecipanti del gruppo di controllo che hanno continuato a seguire le attività di routine previste dal percorso gerontologico. Nelle sessioni ludiche i soggetti hanno ascoltato alcune spiegazioni teoriche relative alle strategie di gioco più idonee e hanno avviato sfide a coppie. Ad essere stati considerati nel disegno sperimentale sono alcuni parametri cognitivi come l’attenzione (Trail Making Test) e alcuni parametri emotivo-psicologici come l’umore e la qualità di vita percepita (Geriatric Depression Scale Short Form e WHOQOL Scale). Il risultato più interessante ha a che vedere con lo stato cognitivo generale: i principali miglioramenti del gruppo sperimentale riguardano l’attenzione e le funzioni esecutive. Tuttavia, ad essere migliorato notevolmente è anche il livello di qualità della vita percepito: in seguito alle sessioni, tutti i partecipanti hanno esibito comportamenti socialmente idonei come l’aiutare gli altri e il creare occasioni di scambio e confronto.


Pilates e benessere psico-fisico
Roh S. Y., Roh S. Y. (2016). The effect of 12-week Pilates exercises on wellness in the elderly. Journal of Exercise Rehabilitation, 12(2), pp. 119-123.
L’invecchiamento è un processo che richiede ragionamenti sofisticati relativi al benessere, inteso come stato che consente ai soggetti di sentirsi bene con sé stessi e di utilizzare al meglio le competenze fisiche, psicologiche, emotive e sociali. Nella terza età si possono verificare alcuni cambiamenti che influenzano queste abilità ed è questo il motivo per il quale negli ultimi anni sono stati messi a punto paradigmi sperimentali che approfondiscono il ruolo di eventuali fattori di protezione. Ad essere particolarmente interessante è il ruolo delle pratiche sportive. Nel contributo qui approfondito gli autori considerano il pilates, inteso come disciplina che incentiva l’allenamento di muscoli, forza e coordinazione e come disciplina che migliora la connessione corpo-mente. Ad essere stato proposto ad un gruppo di donne dai 65 anni è stato un protocollo di 12 settimane durante il quale sono state progettate tre sessioni di pilates alla settimana. Per valutare l’incidenza di queste attività sul benessere, alle partecipanti è stato chiesto in seguito alle singole sessioni di compilare il questionario noto come wellness scale (che contiene items relativi alle considerazioni emotive, fisiche, psicologiche e sociali). Le singole attività hanno previsto una fase di riscaldamento (warming up), di esercizio (main) e di defaticamento (cool down). I risultati sono degni di nota in quanto riferiscono che un intervento di questo tipo sostiene il benessere anziano dal punto di vista fisico, sociale ed emotivo. Questi dati sono in accordo con la letteratura precedente che ci ricorda che il pilates consente di allenare la forza muscolare, di percepire meno difficoltà emotive e di creare legami interpersonali significativi.
Attività museum-based
Johnson J., Culverwell A., Hulbert S., Robertson M., Camic P. M. (2017). Museum activities in dementia care: Using visual analog scales to measure subjective wellbeing. Dementia, 16(5), 591-610.
Numerose ricerche testimoniano l’efficacia degli interventi non farmacologici sulla qualità della vita dei soggetti anziani e dei soggetti affetti da patologie neurodegenerative. Tra le attività più interessanti troviamo quelle artistiche e museali. Sono gli interventi sperimentali più recenti ad aver dimostrato il prezioso link tra arte, musei, benessere psicologico, coinvolgimento intellettuale e inclusione sociale: quando i soggetti hanno la possibilità di osservare opere d’arte in setting museali e di collaborare per la ricostruzione del significato, parametri preziosi come il benessere e l’umore migliorano. Nello studio qui considerato sono state proposte ad un gruppo di partecipanti di età 60-85 affetti da demenza e ai loro caregivers tre attività artistiche in un museo inglese. Nella prima attività art-viewing i soggetti hanno osservato alcuni quadri e li hanno commentati in un piccolo gruppo prestando attenzione alle caratteristiche strutturali (i colori e lo stile) e ai contenuti (i personaggi ritratti e le loro azioni). Nella seconda attività object handling hanno osservato un oggetto artistico (ad esempio, un pettine oppure un sapone del periodo egizio) e lo hanno analizzato considerando i possibili utilizzi e l’epoca di appartenenza. Tra le due proposte artistiche, è stato organizzato anche un break con intenti sociali e interattivi. Grazie a scale di valutazione come la Visual Analog Scale (VAS) è stato misurato il benessere percepito e i risultati sembrano essere particolarmente incoraggianti: durante le sessioni museali art-viewing e object handling il livello del parametro psicologico in oggetto è aumentato notevolmente, così come sono migliorate le dinamiche sociali ed emotive.


Lo smartwatch per il monitoraggio dei parametri vitali
Bhanvadia S. B., Brar M. S., Delavar A., Tavakoli K., Radha Saseendrakumar B., Weinreb R. N., Baxter S. L. (2022). Assessing usability of smartwatch digital health devices for home blood pressure monitoring among glaucoma patients, Informatics, 9(4), 9-13.
Il glaucoma è una neuropatia oculare che può causare la cecità: si stima che ne siano affette 80 milioni di persone, che il problema potrebbe diffondersi a causa dell’invecchiamento della popolazione e che le principali cause abbiano a che vedere con ipertensione e ipotensione. Per monitorare al meglio questi parametri vitali, sono stati messi a punto negli ultimi anni dispositivi digitali come gli smartwatch: il primo è stato messo in commercio nel 2019 e il suo possibile utilizzo è stato testato in questo studio con la popolazione anziana. Durante una prima visita medica, è stato chiesto ad un gruppo di partecipanti di compilare il questionario eHEALS (utile per valutare la loro competenza digitale) ed è stato spiegato loro l’utilizzo dell’oggetto digitale (come leggere le istruzioni relative alla pressione, quando misurare il parametro e come trasferire i dati sull’APP di riferimento). Dopo una settimana e durante la visita di follow-up, ai pazienti è stato chiesto di compilare altri due questionari: il SUS (che misura l’usabilità dell’oggetto) e il PSSUQ (che misura il livello di soddisfazione). Per quanto riguarda i primi risultati, il questionario eHEALS ha mostrato una buona competenza digitale di partenza, mentre il PSSUQ un buon livello di soddisfazione. I soggetti hanno dichiarato di non provare fastidio con il device e di riconoscere l’impatto positivo sullo stato di salute: lo smartwatch, infatti, ha consentito di raccogliere dati preziosi relativi alla pressione, ma anche all’attività fisica e ai pattern del sonno. Tuttavia, alcune possibili problematiche devono essere considerate quando vengono proposti strumenti di questo tipo alla popolazione agé: ad esempio, le difficoltà connesse all’utilizzo del Bluetooth, al dover indossare l’orologio con costanza e al dover misurare la pressione durante la notte. Ragionando sulle possibili evoluzioni tecnologiche, particolarmente importanti saranno tutti quei dispositivi che – grazie ad un numero sempre maggiore di sensori – misureranno parametri sofisticati come la temperatura corporea e ridurranno la necessità delle visite ambulatoriali. Al tempo stesso, sarà fondamentale prevedere un’assistenza tecnica e una formazione per tutti gli utenti.